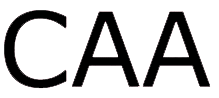Tempo e clima estremi

Calore e gelo
Il cambiamento climatico sta chiaramente portando a cambiamenti nei modelli meteorologici, in particolare la frequenza, l’intensità, la durata e la tempistica degli eventi atmosferici e dei loro estremi, con un conseguente aumento dei record di calore e delle ondate di calore, con un impatto sociologico, ecologico e fisico sul nostro ambiente. Dal 1951 al 1980 sono state registrate temperature estive eccezionalmente elevate in meno dell’1% della superficie terrestre. In quel caso, si riteneva che le temperature eccezionali si verificassero teoricamente solo con una probabilità massima dello 0,13%, quindi molto raramente. Tuttavia questi eventi, allora rari, sono stati registrati in circa il 10% della superficie terrestre nel periodo dal 2001 al 2010. Inoltre, dal 1979 al 2013 il periodo annuale in cui possono verificarsi gli incendi boschivi è aumentato in media di circa il 19% su scala globale, anche se va notato che il fattore scatenante degli incendi boschivi è spesso di origine umana (ad esempio, negligenza o incendio doloso).
Sebbene possa sembrare contraddittorio, il cambiamento climatico sta anche contribuendo a un inverno più estremo: poiché il riscaldamento dell’atmosfera trattiene più vapore acqueo, di conseguenza, più tardi nel corso dell’anno, quando le temperature si abbassano e condensano questo vapore, si verificano nevicate più abbondanti. Questo cambiamento è chiaramente visibile nell’immagine a destra: le variazioni di temperatura causate dai cambiamenti climatici influenzano i modelli meteorologici. Nonostante il riscaldamento globale, quindi, gli episodi di freddo estremo possono ancora verificarsi a livello locale, anche se si prevede che si verificheranno con minore frequenza.

Piogge e alluvioni
Le piogge, e in particolare le precipitazioni abbondanti, si riferiscono a un fenomeno in cui la quantità di pioggia (o di neve) registrata in un determinato luogo supera sostanzialmente la norma e si protrae per un periodo di tempo prolungato. Il cambiamento climatico e il riscaldamento globale possono influenzare l’intensità e la frequenza delle precipitazioni: con il riscaldamento dell’atmosfera, aumenta la quantità di acqua che evapora da oceani, laghi e suolo e che finisce nell’aria. Gli scienziati hanno stabilito che l’atmosfera è in grado di trattenere un 4% in più di vapore acqueo per ogni 1°F in più di riscaldamento. Di conseguenza, l’aria assorbe più vapore acqueo, la quantità di vapore nell’atmosfera aumenta e quando si condensa si verificano precipitazioni abbondanti e intense. Gli impatti delle precipitazioni intense includono le seguenti conseguenze: erosione del suolo, danni alle colture e aumento del rischio di inondazioni.
Nella media globale, le precipitazioni intense stanno diventando sempre più frequenti e violente, sia nelle aree secche che in quelle umide. Attualmente circa il 18% di queste precipitazioni può essere attribuito al riscaldamento globale. Tuttavia, l’aumento della frequenza delle precipitazioni estreme può variare notevolmente da regione a regione. Il Mediterraneo, ad esempio, si è surriscaldato notevolmente negli ultimi decenni. Di conseguenza, una maggiore quantità di acqua evapora dalle sue acque e viene trasportata verso nord grazie a una certa disposizione delle aree di alta e bassa pressione (depressione mediterranea); questo fenomeno può portare a un aumento delle precipitazioni intense e delle inondazioni in Europa centrale.

Siccità
È difficile formulare una definizione universalmente condivisa di siccità perché la scienza riconosce e classifica diversi tipi di siccità. I fattori naturali determinano dove e quando si verifica la siccità.
I meteorologi definiscono la siccità come un periodo prolungato di tempo secco causato principalmente dalla mancanza di precipitazioni, ma può anche essere vista come uno squilibrio prolungato tra precipitazioni ed evaporazione. Il riscaldamento globale porta a un’evaporazione più intensa dell’umidità del suolo a livello locale e, di conseguenza, a una maggiore probabilità che in determinate aree si verifichino più rapidamente siccità più intense. Inoltre, dalla metà del XX secolo, le aree più aride della Terra si sono ampliate, soprattutto in Africa, Europa meridionale, Asia orientale e meridionale, nonché in molte parti delle latitudini settentrionali, medie e alte. Questa situazione provoca una grave carenza d’acqua per le popolazioni che si trovano in queste aree e danneggia il nostro sistema ecologico.

Cicloni tropicali
A causa dei cambiamenti climatici, i cicloni tropicali saranno probabilmente influenzati in vari modi: ad esempio, si prevedono le tempeste più forti con un’intensificazione delle precipitazioni e della velocità del vento. Tuttavia, tra le possibili conseguenze del cambiamento climatico vi sono anche una diminuzione della frequenza complessiva e un’estensione verso il polo in cui i cicloni raggiungono la massima intensità.
I cicloni tropicali si originano al di sopra degli oceani a una temperatura di 26°C, perché per formarsi hanno bisogno dell’impulso di aria calda e umida. Con il cambiamento climatico aumenta la temperatura dell’acqua e di conseguenza anche la sua evaporazione, il che significa che viene fornita più energia alle tempeste. Si prevede inoltre che, a causa dell’aumento del vapore acqueo nell’aria, i futuri cicloni saranno accompagnati da precipitazioni più intense. D’altra parte, il riscaldamento globale riduce i movimenti dell’aria verso l’alto e verso il basso, mentre aumenta i flussi orizzontali, che si sovrappongono l’uno all’altro e differiscono per direzione e/o velocità del vento. Ciò accade, ad esempio, ad altitudini più elevate nelle regioni di origine dei cicloni atlantici in Africa centrale e occidentale. Questa tendenza può ostacolare la formazione dei cicloni tropicali, per cui il loro numero totale potrebbe diminuire.
I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale faranno sì che l’intensità media globale dei cicloni tropicali si sposti verso tempeste più forti. L’intensità di queste tempeste aumenterà del 2-11% entro il 2100, con un aumento dell’ordine del 20% delle precipitazioni che, di conseguenza, provocheranno maggiori danni al loro passaggio.

Temporali
I cambiamenti nei temporali sono già evidenti quando si verificano al giorno d’oggi e la causa è il cambiamento climatico: si prevede che in futuro ci saranno più temporali estremi di breve durata a causa del riscaldamento globale. Studi ed esperti hanno rivelato che l’aumento delle temperature intensificherà in futuro le precipitazioni estreme a un ritmo molto più elevato rispetto alle precipitazioni medie, con una tendenza a un forte aumento dei temporali brevi ma violenti, caratterizzati anche da forti venti o trombe d’aria. Questi eventi meteorologici estremi causeranno danni per miliardi di euro.
I temporali sono il risultato dell’interazione di una serie di fattori diversi: affinché si verifichino temporali molto forti, è sempre necessario una sorta di “meccanismo di sollevamento” che inneschi la risalita dell’aria, oppure forti correnti orizzontali sovrapposte, diverse tra loro per direzione e velocità del vento. In particolare, il movimento ascensionale dell’aria umida e calda gioca un ruolo importante come fonte di energia nella formazione dei temporali. Il vapore acqueo contenuto in quest’aria si condensa, liberando energia termica e intensificando così il processo di formazione dei temporali. Il riscaldamento globale fa sì che l’atmosfera si riscaldi e quindi assorba più umidità, rilasciando più energia durante la condensazione. Si prevede quindi che, in presenza di queste condizioni meteorologiche, si verifichino temporali più intensi.
Tuttavia, a causa dei numerosi fattori di influenza e della rilevazione incompleta dei temporali, è difficile formulare un’opinione universalmente condivisa sul loro sviluppo globale e sugli eventi meteorologici associati.
Una volta formatisi, i temporali hanno il potenziale per diventare ancora più intensi e avere conseguenze più devastanti di quelle che hanno già avuto nel clima attuale.

Nevicate
La temperatura è il fattore principale che determina se le precipitazioni cadono al suolo sotto forma di neve, ghiaccio o pioggia.
L’aumento delle temperature sta già influenzando i modelli di nevicata. Il senso comune ci dice che in un clima più caldo ci saranno meno nevicate, perché le temperature più calde probabilmente faranno sciogliere la neve e la trasformeranno in pioggia prima che colpisca la terra, ma, controintuitivamente, il riscaldamento globale potrebbe in realtà far sì che le regioni più fredde sperimentino maggiori nevicate nel breve e medio termine. Il motivo per cui questo può accadere è che l’aria più calda “trattiene” più umidità (gli studi hanno dimostrato circa il quattro per cento in più per ogni grado Fahrenheit) e questa umidità aggiuntiva può cadere sotto forma di neve quando le temperature sono inferiori allo zero. Ciò che la gente non sa della neve è che la neve stagionale, in particolare, è una parte importante del sistema climatico terrestre. Quando la neve si scioglie, l’acqua contribuisce a riempire fiumi e bacini idrici in molte aree. È importante notare che i cambiamenti nella quantità e nella tempistica delle nevicate possono influenzare la quantità di acqua disponibile per l’uomo.
La neve agisce come una coperta che protegge il suolo e i suoi organismi dalla variabilità della temperatura dell’aria. Quando il suolo gela, non può assorbire facilmente nuova acqua liquida e questo porta a un maggiore deflusso e a potenziali inondazioni. Poiché una frazione maggiore delle precipitazioni cade sotto forma di pioggia piuttosto che di neve, aumenta anche il rischio di inondazioni.

Temperature estreme (ondate di calore)
Le ondate di calore estremo stanno aumentando in frequenza e intensità a causa del riscaldamento globale. Il cambiamento climatico sta rendendo le ondate di calore, che in passato erano eventi sporadici, più lunghe, più estreme e più frequenti di prima.
Un nuovo studio, pubblicato il 26 luglio 2021, mostra come le ondate di calore da record e di lunga durata siano sempre più probabili. Le ondate di calore sono qualcosa di naturale, ma intensificate dalle emissioni di gas serra. In particolare, durante l’estate nell’emisfero settentrionale, la metà settentrionale del pianeta è inclinata verso il sole, il che aumenta le ore di luce e riscalda l’emisfero.
Le ondate di calore si verificano quando la pressione atmosferica al di sopra di un’area si accumula a causa di un sistema di alta pressione (anticiclone). In questo modo si creano le condizioni che provocano l’abbassamento della colonna d’aria che si comprime, si riscalda e spesso si asciuga. L’aria che sprofonda agisce come una calotta (nota anche come cupola di calore), intrappolando il calore latente già assorbito dal paesaggio e provocando un ulteriore aumento della temperatura dell’aria. Sebbene questo accada ogni estate, gli effetti sono ora amplificati dal riscaldamento globale. Questo è allarmante per tutte le conseguenze che le ondate di calore provocano, come ad esempio gli incendi, per non parlare delle complicazioni che queste ondate portano alla salute umana: quando fa molto caldo il corpo umano non è in grado di raffreddarsi efficacemente, infatti normalmente il nostro corpo può raffreddarsi attraverso la sudorazione, ma quando l’umidità è alta, il sudore non evapora così velocemente, portando potenzialmente a colpi di calore e ad altre complicazioni (legate al cuore) soprattutto per gli anziani.